
https://podcasters.spotify.com/pod/show/daniele-locchi


li trovate tutti qui:


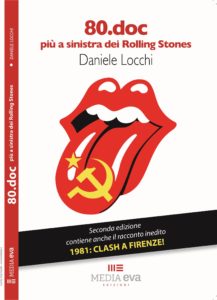


questI anche su
effigi edizioni
cdpadver@mac.com
e per questi
PROGETTI EDITORIALI


info@apicelibri.it

C’è un uomo, un cane e una fila di case. Quartiere alto, vista sul parco inclusa. Dalle finestre dai vetri zigrinati si notano solo ombre. Segretarie, clienti, consulenti. Studi legali affollano il primo piano. Sopra, l’universo di appartamenti gelosi della loro appartenenza al mondo che non teme la becera mescolanza dei gesti e delle grida di strada. L’uomo guarda il consueto scenario del rito del rientro. Sono donne alte, bionde, impellicciate. Sono bambini con i pantaloni corti e le ginocchia sbucciate. Sono uomini in grigio, in nero, in blu. Molti con la borsa di pelle, chiusa da una cinta forata da punte di metallo cromato. Le donne hanno ciprie che intiepidiscono i lineamenti stanchi e capelli perfetti, laccati, con onde del mare biondo cenere a disegnare la movenza di sentimenti che sono andati via senza avvertire, come i maggiordomi non fanno e gli autisti nemmeno.
L’uomo sale con il suo sguardo da funambolo che si aggrappa alle grondaie, supera le ringhiere dei terrazzi, si sospende tra l’uno e l’altro, balza su agganciandosi alle mattonelle che avanzano oltre al linea del ferro battuto che divide la bellezza dello sguardo dall’orrore del salto indeciso tra il cadere volando o il volare cadendo, per la libertà di una fuga senza meta. Per un momento lascia la sua anima colorata in braccio allo sguardo equilibrista e osserva il cane. Un cane piccolo, di quelli che sembrano finti e schiumano rabbia per non essere nati liberi. Un cane vero, piccolo. Che mugola e abbaia, in sordina, come ogni cane di un palazzo dal portone importante ha imparato a fare, pena la cacciata dall’eldorado di Purina. Si china e sussurra alla palla di pelo.
“Buono Alaforte, sennò è la volta che ti faccio fare un bel volo dall’ultimo piano..una disgrazia ahimè, non ho idea di come sia potuto succedere, era come un figlio per me…che dolore…”
Alaforte che non ha mai cessato di odiare quella voce e quel nome così poco da Jack Russel, capisce anche il senso non solo il suono delle parole. E il marciapiede torna a zittirsi, una pausa lunga come la distanza tra il pollice e il medio prima dello schiocco.
L’uomo torna dal suo sguardo. Eccoci. Casa. Dolce. Casa. Un attico. Un appartamento. Grande come tutta la pianta del condominio di sotto. C’è una finestra aperta di fianco, sul lato nascosto perfino ai piccioni. Lo sguardo entra, attraversa il salone con quadri di chissà chi alle pareti, mobili antichi, c’è un comò, un settimino, un armadio vetrina, una scrivania in ribaltina, un about jour al tavolino ovale con il pianale in vetro, che se ne resta zitto di fronte al camino. Sedie, poltrone, riviste addormentate. Quattro finestre, una di fronte all’altra e due che fanno da gemelle sulla vista del parco che ha acceso le sue candele ai lampioni in attesa di farle diventare stelle alla notte delle signore dalle taglie forti che tramandano sesso. Amanda, Luisa, Morena, Luana…ogni nome un odore di profumo grezzo, invadente, offensivo. Ogni nome una doccia che lava via il disgusto di sapere di essere solo anche con qualcosa di tuo nelle cosce di un’altra. L’uomo le chiama “le streghe del Parco”, le guarda con vergogna mentre vede la sua forma seminuda alla luce della luna tra le braccia dell’erba che gli solletica le anche scoperte quel tanto che basta. Eppure il chiarore delle stelle quelle signore le disegna belle, proprio come il profilo di sua madre che fa capolino dal quadro che inaugura la parete del corridoio. Per fortuna, si dice, il Parco non ha specchi, ma solo alberi discreti e complici. Alaforte strepita, vuole tornare alla cuccia di legno che il padre dell’uomo gli ha costruito pezzo dopo pezzo, prima di addormentarsi per sempre appena finito l’ultimo colpo di martello. Un colpo più debole, quasi un addio del martello col chiodo e del cuore dal mondo. Il corridoio adesso è buio, le mani dello sguardo dell’uomo strusciano la parete fino scovare l’interruttore. Un flash a percorrere le mille possibilità di trovare la cucina, fino a fermarsi davanti all’odore di soffritto che lo ha da sempre rivestito per le corse alla fermata del bus del liceo. Ai fornelli una signora fatta cuoca con i capelli raccolti in una crocchia appena accennata, quasi un legame ai capelli bruni per non farli correre lontano, dal collo alle orecchie e poi sulla fronte, aggiusta una pentola grande sul fuoco. Lo sguardo dell’uomo si avvicina in punta di ciglia, le soffia da dietro una lenta carezza d’aria sul collo. La donna signora e cuoca si gira di scatto mettendo in mostra due topazi incastonati tra gli zigomi e le sopracciglia che fermano le poche gocce che le affrescano la fronte richiamate dal calore della magia del fuoco che insaporisce la vita. Vorrebbe abbracciare quell’uomo così troppo giovane da non poterle che essere figlio. Ma non c’è niente davanti a lei, se non il desiderio forte di un ricordo. E quell’uomo vorrebbe sorriderle, scostandole con un dito gentile la ciocca ribelle che le adorna la guancia, e dirle una frase, breve, un soffio di parole che si vanno ad accovacciare davanti ai topazi lucidi.
“Ciao, mamma. Come stai?”. Ma lei non lo vede e lui non la sente. C’è solo lo sguardo, di un uomo, laggiù, con un piccolo cane e una strada con una fila di case.

TORTORELLA, LA MASCHERINA E SANTO SPIRITO.
Tortorella si sveglia tutti i giorni alle 5.17. Se fosse un uomo “normale” magari si domanderebbe il perché di quelle diciassette. Ma gli uomini “normali” spesso si fanno domande che non servono a molto. Quindi lui non se le fa. Si sveglia, si tira su a fatica, va in bagno, poi in cucina, si prepara una bella colazione fatta di biscottate sbriciolate e cortecce di arance, se la gusta in sala da pranzo e poi va in camera, fa il letto, torna in bagno si fa doccia e barba e se ne va. Tutto nei 20 metri quadri del suo loculo di borgo san frediano, che ha trovato perfettamente arredato una decina di anni fa. Quando ancora le case le davano in affitto, prima della Crisi del Virus. Ha pagato per un paio di mesi, poi il Grande Crollo ha spazzato il mondo. Proprietari inclusi. Meglio così, si dice tutte le mattine alle 5.18. Senza lo stipendio da cameriere, come lo avrebbe potuto pagare? Da quel tempo, vince chi c’entra. E cambia il lucchetto alla porta.
Ma ora è tempo di uscire ed andare a lavorare.
Il suo uscio coincide con l’inizio di un tunnel, una rampa per disabili unta dalla morchia del motore del riscaldamento condominiale posizionato appena sopra la sua testa. Si aggrappa alla ringhiera laterale bollente con i guanti da forno che gli hanno dato a mo’ di TFR il giorno del rogo della pizzeria, frutto dell’ultimo gesto d’amore disperato di Tonino Pastafresca che si lasciò bruciare vivo incatenato alla friggitrice. Guadagna a fatica la porta di uscita dell’edificio che dà sulla strada. Afferra la maniglia infuocata la gira in giù ed esce.
L’aria fresca lo prende alla gola come fosse la mano di Tenaglia. Non lo sopporta proprio, quel tipo. Per andare a lavoro deve per forza passargli davanti alla vetrina dello studio, quella dove prima dondolavano in bella mostra prosciutti e cotechini. E ogni volta lo vede seduto tutto tronfio alla scrivania della sua agenzia di runner usa e getta. Nonostante le denunce di qualche ex sindacalista che ha rifiutato di riciclarsi in Navigator, la premiata ditta Paga&Arriva prospera indisturbata. Il bassissimo prezzo della pizza consegnata a domicilio fa passare in secondo ordine la diceria che a nessun cliente sia mai stata portata una pizza dallo stesso runner. Un euro in meno della concorrenza, il prezzo esatto della coscienza.
Ma Tortorello oggi ha fretta, lascia i pensieri sul marciapiede stretto e scalcinato della via e si affretta a raggiungere Piazza Santo Spirito. Non ha molto tempo, la spazzatrice della Quadrifoglio di solito arriva alle 6 a ripulire il selciato e le aiuole dei detriti dell’ennesimo aperisabba. È arrivato. Prima di cominciare, si piazza proprio in mezzo alla piazza, con le spalle alla fontana di plastica con i getti di amuchina che ha sostituito la precedente fontana in acqua ed ossa, e fissa per alcuni interminabili minuti, che per lui sono minuscoli attimi, la facciata della chiesa. Guarda le meraviglie del rosone, la perfetta e asciutta simmetria delle porte, la croce che sovrasta il frontone e piange. Lo fa in silenzio, senza alcuna idea sul motivo che lascia a quelle lacrime il compito di disegnargli le rughe del viso. Forse, il suo modo di pregare. Forse, una tristezza profonda, che lo avvolge come la solitudine che imbavaglia tutta la città ormai da anni.
Si scuote. Sono le 5.37. Bisogna muoversi. Tira fuori dalla borsona i suoi strumenti di lavoro. Un lungo bastone di ferro a tre punte e un paio di sacchi neri della nettezza formato condominio. Obbiettivo. Raccogliere tutte le mascherine chirurgiche usate e gettate dal popolo dell’aperisabba, l’appuntamento quotidiano degli irriducibili dell’intera città che avviene tutte le sere in barba all’Editto dell’Assembramento, tollerato dal Comitato di Controllo Epidemico per dare sfogo a quelle tendenze trasgressive che altrimenti potrebbero indirizzarsi verso obiettivi sensibili, come raccomandato dal Dipartimento Psicologico del Consiglio dei Ministri Tecnico Scientifici.
Tortorella si mette in azione. Nel suo campo, è un fulmine di guerra. Nel giro di un quarto d’ora, ha ripulito la piazza e ha riempito fino all’orlo i due sacchi.
Se ne torna a casa, strascicandoli per terra, non tanto per il loro debole peso, quanto per fare quel minimo di rumore che basti a svegliare dal letargo il resto del mondo. È il suo modo di protestare per quel tormento di sopravvivenza che sembra non avere più fine. Qualche insulto arriva dalle finestre, pane per uno che non regge i falsi perbenismi e le giaculatorie dei convenevoli. Meglio una offesa urlata in faccia, di una mascherina che ti sorride come fosse paresi.
Ripassa davanti a Tenaglia, che lo squadra dal vetro come volesse cucinarselo in umido. È odio puro, manifesto, minaccioso, quello che trapassa in entrambe le direzioni il vetro umido dell’ufficio.
Prima o poi il ferro a tre punte troverà la sua destinazione finale. O forse quelle mani di pietra ridurranno il suo collo ad un fumetto. Prima o poi. Oggi è ancora poi, il lavoro pressa e non è ancora giunto il momento della resa dei conti. Chissà, magari quel ferro lo sbudellerà così potrà vedere se è vera la diceria del Cannibale dalle mani di pietra.
Lo lascia al suo momentaneo destino di massacratore di motorini umani e fa ritorno al mini loculo, strusciando i piedi sulla rampa in modo da mitigare con l’attrito la velocità prodotta da quel piano inclinato unto di morchia.
Entra, va alla vasca e ci rovescia il prezioso carico di mascherine accartocciate e sporche. Riusate e gettate. Apre il rubinetto ed aggiunge al carico di cloro immesso giornalmente nell’acqua non potabile un chilo di candeggina ad alta concentrazione. Passa il carico sotto la mitragliata del getto forte della doccia e lascia che il liquido saponoso passi la griglia posta sopra il fondo vasca e se ne vada a far danni al lungomare di Marina di Pisa.
Un altro, ennesimo passaggio e il gioco è fatto. Tortorella guarda soddisfatto il carico di mascherine sanificate che se ne stanno appoggiare sopra la rete. Le raccoglie in un cesto e le butta nell’asciugatrice che se ne sta sotto il lavandino. Tempo pochi minuti e saranno pronte per essere consegnate ai tagiki che controllano il contrabbando delle riusa e rigetta. Non è molto onesto, come lavoro, ma qualcosa si deve pure fare, per campare.
Ma non è questo il suo vero obbiettivo. Le mascherine servono per sopravvivere. Ma per vivere serve altro. Quello che è rimasto sulla griglia del fondo vasca. Una bella paranza di merce rara, che non ha mai pensato di poter vendere. Centinaia di pezzi al giorno, che ripone con cura in una borsa rossa e capiente. Deve affrettarsi. Tra poco apre la scuola di via de Serragli. Esce di nuovo, cammina veloce e dopo un po’ di passi , arriva e si piazza di lato all’ingresso. Apre il banchino che è solito lasciare appoggiato accanto al portone, assicurato ad una grossa catena.
Pone con attenzione sopra la sua mercanzia. Che ha una grande differenza da tutte le altre in commercio. Non si vende. La offre gratuita a tutti i bambini. Ha finito di montare la mise en place. Appena in tempo; i primi stanno già arrivando, con gli zainetti alle spalle e le mascherine multicolor in viso. Saranno loro a scegliere il sorriso che più gli piace. Uno per ogni bambino. Non ha paura che finiscano. Anche perché i sorrisi, non si usano e non si gettano. Si donano, e la speranza torna a scaldare i piccoli cuori

L’acqua arrivò veloce
nel silenzio dell’alba.
Mulinò le sue braccia di morte
in una stretta fredda alla gola
di una città addormentata
la percosse con un colpo di maglio grigio
l’avvolse come un topo il pitone
e poi la lasciò.
Spogliata
Sporcata
Violata
La mollò sola con un figlio di fango
che non aveva più madri da piangere
nè sorrisi da vendere
sui carri imbanditi di San Lorenzo.
Solo i riccioli sporchi degli angeli
chiamati a raccolta da un dio distratto
che aveva salvato i gioielli degli orafi
e annegato i cavalli del parco
la aiutarono a rialzarsi
senza nemmeno chiederle il come.
La ripulirono con gli stracci
delle mani e degli occhi,
innamorati della vita e dell’arte
che non è paradigma ma mirabile essenza
e le sorrisero di un sole inventato
con la folle lucidità
di una generazione di fiori.


Un’unghia di terra sfiora l’Autunno
Il mondo respira al suono dell’onda
Un grammofono al Sapore di Mare
Luce che avvolge e si perde nel tempo

Notte.
ali di luna, stelle nascoste
civette dondolano cime d’ alberi
nell’ora del no sense
di una storia che nessuno ha scritto
e mai pubblicata
per mancanza di scrittori poeti ed editori
tra i fantasmi fatti di creta
i musei d’insonnia galoppano
lungo il controviale a scansare corpi
appoggiati al muro di un desiderio
che puzza di rabbia e di voglia repressa
di crepacci di solitudine
e abissi di violenza.
Notte
una macchina passeggia in lontananza
in un’altra il dolore lampeggia
non avere altro che fare
che guardare
sogni travestirsi di promesse
svaniranno alle prime luci negli occhi dell’alba
dentro una tazzina smorta
in una sgommata impaziente
nel pianto ingoiato con la brioche
avvelenata dal rumore di un tir
che si fa beffe del tuo sorriso
stampato sul retro di un giornale
che non ha più pagine
ma solo inchiostro nero
nero come la notte che ti aspetta
appena fuori dall’ultimo raggio di un lampione.
.

Nuvola senza cielo
miscuglio di molecole
idea confusa d’anima
necessità del nulla
leggera sinfonia
di luna, aria e terra
in una cicca accesa
che appesa ad un accordo
nasconde il mondo
nel vuoto di un bicchiere.


Estemporanea.
La vita è estemporanea.
Svuotata del tempo
si disegna sul vetro della fantasia
si stende nuda sul cuscino dei racconti
si avvolge in tende di ricordi
si agita inquieta nella stanza dei dubbi
fugge dalla finestra del desiderio
corre libera sul prato della follia
e scompare piano piano
dalla vista del cieco
sussurrando ruscelli
promettendo valanghe
dispensando carezze.
Pugni chiusi a celare la polvere
che la mano di un dio abbandonato
tiene inutile con sé.
Standard
Quanto è alto?
Quanto pesa?
Come si misura?
Chi lo fa?
Quanto è lungo?
Quanto è largo?
Quanto dura?
Voglio uno standard
da abbracciare la notte
al posto di un cuscino
e giocarci di giorno
al posto di una palla.
Quanto è?
Quando è?
Quando siamo
standard?
Abbiamo tutti
uno standard da piangere
da ridere
da vivere?
Ecco.
Vivo in uno standard.
Forse sono uno standard.
E sorrido.
Mentre a Liegi
lo Standard
non va oltre il pareggio
contro il Bruges.

Io sono pazzo
mi avverto annichilito nello spazio
che si rastrella astratto nei pensieri
in scimitarre d’odio annuvolate
ho chiuso anche le orecchie alla memoria
non riconosco più le lune a oriente
raggi dalla ragione disegnati
virano lesti in seppie di ricordi
sono frammenti accesi di emozioni
tizzoni degli amori abbandonati
al margine di strade polverose
e sassi, come uccelli addormentati.

(Pasqua 2018)
Fammi entrare
dentro la tua oscurità
riposami nelle pieghe del mondo
appartami in mute parole
vestimi di una preghiera stanca
riparami.
Non ho più voce per vedere
nè mani ad accompagnare
una figlia nel destino
ma solo un flauto
di tristezza e solitudine
tra le macerie di un sogno tradito.

Gli scomodi
hanno ali annerite
dal gasolio benpensante
e gridano
attaccati al collo
di una bottiglia di birra
aperta
al confine del Cielo
mentre gli angeli
lampeggiano nel blu.