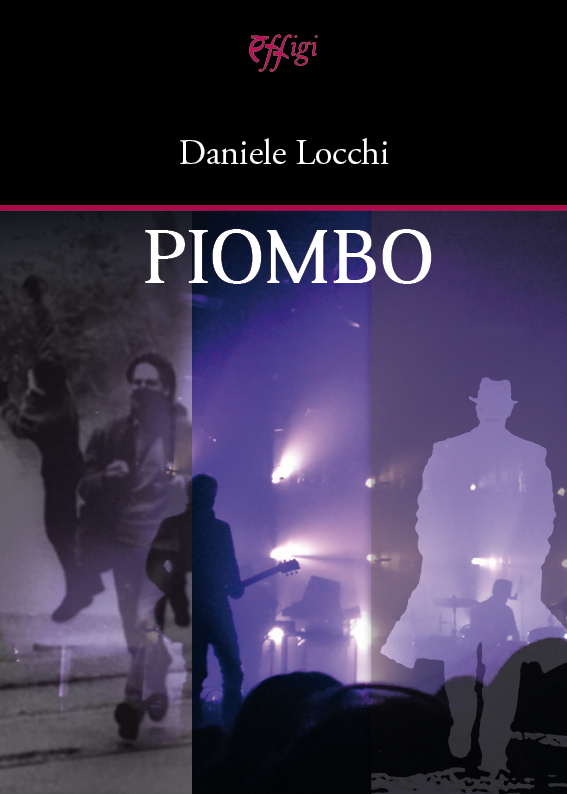LA MUSICA E’ FINITA
primo capitolo

VIVIENNE
Qualcuno mi ha chiuso la notte. Cavolo. Odio svegliarmi. Così mi devo alzare. Vaffanculo.
Per Vivienne la colpa è tutta di Camilla. L’ha svegliata facendole il solletico alle labbra con le vibrisse. Inutile sgridarla. Fosse un barboncino, ci sarebbe qualche speranza. Ma una soriana con le orecchie appuntite e gli occhi verdi non dà scampo. Fa capire fin dal primo momento del ménage che il suo mondo ha una precisa gerarchia, con lei che lo sorveglia acciambellata in cima.
Quindi prima vengono le vibrisse, poi i suoi libri. Lei scrive, le parole sono tante bambine con i grembiulini rosa che giocano sul prato. Le guarda, le osserva e ognuna di loro le racconta una storia. Le scriverebbe tutte, potesse. Tutte le parole del mondo, tutte le bambine del mondo, tutte le storie del mondo. Ma per sua “fortuna”, esiste Alberto, l’editor.
“Vivienne, sei lunga. Possibile che non capisci? Se fai più di 200 pagine, chi vuole acquistarlo si blocca. Lo prende in mano, lo rigira, lo soppesa e poi lo rimette sullo scaffale e si va a comprare un bel tascabile da 120, magari quello che in copertina ha in bella mostra la fascia gialla del successo del solito commissario. Non ti andrebbe invece di scrivere una bella storia con la commissaria Megrette?”.
“Alberto, ti adoro ma quando fai il cretino ti ucciderei. Per tua fortuna siamo on line, sennò ti farei sentire quanto pesa un libro mio. Non trattarmi come un’esordiente! Sono al ventesimo romanzo, tutti pubblicati con voi e non me ne importa un fico secco di un lettore con la bilancia”
“Non volevo dire questo, Vivienne. Però scrivere è una professione e ci sono delle regole di mercato”
“Il mercato è affare tuo. Il mio è scrivere. Restiamo così. Lo sai che non ti vorrei mai tradire con nessun altro. Però rimani lì, sulla soglia”
“Ma quale soglia, siamo on line, cristo…”
“A voi uomini manca la fantasia. Siete limitati. L’unica fantasia che riuscita a concepire è una scena erotica. E nemmeno avete idea di cosa sia l’erotismo…comunque, resta sulla soglia della mia pallida attenzione e basta con le prediche. Se vuoi tagliare, provaci. Tanto poi l’ultima parola spetta a me. E non vorrei che fosse anche l’ultima con voi. Non credo che Saronno sarebbe soddisfatto di te per avergli fatto perdere la vincitrice dello Strega…”
“Sì, va bene Vivienne, ma quello Strega era di dieci anni fa…”
“E allora? Mica ha la data di scadenza come il tuo contratto con Saronno”
“Ma perché non troviamo un accordo? Dai… sei una star, ma le leggi …”
“E anco…con..ggi…me…to…”
“Eh? Non ti capisco…”
“…non c’è…nea”
“Ah, allora ti chiamo più tardi”
“Pr…”
“Come?”
“…ova”
“Ok ma cambia gestore, è sempre fuori copertura…”
Fossi matta. Resta al palo, bamboccio.
La libertà per me è la penna che riempie di nero il foglio bianco. Ce ne sono altre come me? Impossibile. Quindi caro Alberto, stattene alla larga da me. Tanto Saronno lo sa che valgo quanto vendo. E io vendo bene, perché scrivo bene. Non scrivo con il contatore. Non scrivo con i piedi. E nemmeno con le mani. Scrivo con le vibrisse di Camilla, la mia anima di libertà nascosta nel pelo di una soriana con le orecchie a punta e gli occhi verdi. Bella questa, meglio che me la scrivo.
….
PABLO
Suonare la chitarra è come fare scorrere l’acqua sulla roccia. L’acqua è tenera, la roccia è forte. Ma l’acqua ha unghie trasparenti, con quelle scava la roccia. È per questo che quelle della mano destra me le tengo lunghe. Perché se hai unghie lunghe, suoni da Dio. E’ semplice. Bisogna essere bravi a scrivere canzoni ed avere unghie per suonarle.
Pablo ha sempre scritto canzoni, sui muri, sul quaderno, sulle mani. Un cantautore deve sapere scrivere dappertutto, pure sulla sua pelle. Deve cogliere l’attimo. L’attimo è breve. Scappa veloce. Bisogna prenderlo al volo. È come un messaggio nella bottiglia. Message in a bottle. Avrebbe voluto scriverla lui, quella. Ma Sting è Sting. La bottiglia è l’attimo, il messaggio è il seme. Intanto il seme è stato piantato, ora bisogna aspettare.
Per scrivere una canzone ci vuole un seme. Si pianta in testa quando meno te lo aspetti,
Pablo è al Mexcal in coda per andare in bagno. Beh, sarebbe meglio chiamarlo con il suo vero nome. Cesso. È lì a gambe strette che aspetta che si apra l’unica porta di quell’unico cesso dove ci vanno tutti senza domandarsi se è quello delle donne oppure no. È lì, e intanto che la fila non scorre e che le facce di quelli che aspettano diventano sempre più bianche, è lì che pensa, per non patire troppo nell’attesa. Ci sono quelli che pensano per patire e quelli che lo fanno per non patire. Lui è uno di questi. Si mette a pensare, così non deve sentire tutto il male del mondo, che poi è solo il suo male, ma soffre meno se pensa sia quello di tutti.
Però lì, in fila, non pensa a una canzone. Pensa alle cosce di Louise. Sono grosse, più delle sue. Anche lei è più grossa di lui. Sembra un cervo volante. A guardarla così non si direbbe che possa volare. E invece, quando il Maka mette il suo pezzo, la Louise posa sul banco del bar quello stivale di birra che sembra l’Italia da bere e dopo un rutto liberatorio se ne va in pista. Non ci si butta, lei. Semplicemente sposta l’aria intorno con le persone dentro e ci passa in mezzo, come fosse Mosè. Una Mosè dark con il chiodo a punta, lo stesso che portava suo babbo. Lui è morto per una buca sulla FiPiLi, era con il fratello sulla moto. Una strada maledetta. Li ritrovarono stesi, sdruciti come li avessero messi in una trebbiatrice, abbracciati nell’ultimo riff della loro vita. Louise era una bambina, la mamma l’abbracciò forte forte e pianse ininterrottamente insieme a lei per due giorni e due notti. Poi, in un attimo strano come sono tutti gli attimi che fanno correre le nuvole come motociclette nere nel cielo bianco, lei si staccò da quell’abbraccio disperato, prese il chiodo del babbo sdrucito che era sul letto, se lo mise addosso che sembrava la schiacciasse da quanto era peso e grosso e smise di piangere. Pare che nessuno l’abbia più vista piangere, la Louise. E che non sia stata più triste. Non possiamo essere proprio sicuri sia vero. Però a guardarla mentre vola in pista che sembra una ballerina in tutù con un chiodo sopra, potrebbe essere vero. Non piange, sorride da sola e balla. Fino alla fine di quella canzone. Poi torna al banco e ordina un’altra Ceres.
Insomma stasera Pablo sta pensando alle belle cosce tornite della Louise mentre si tiene le sue sempre più strette, e proprio in quel momento gli arriva la bottiglia dell’attimo con dentro il seme. Da da da, dadadada, da da da, dada. Sulle prime i da da si assomigliano tutti come i bambini appena nati. Poi crescono e diventano canzoni. A lui funziona così. Prima arriva il da da e poi ci mette la voce della parola. È convinto che le canzoni siano già tutte scritte, musica e parole, come fossero piante, alberi, cespugli del cielo e che i loro semi se ne stiano chiusi in uno sterminato magazzino che sembra un archivio ma non è così brutto. Un magazzino celeste, sospeso tra le nuvole e il buio. Un enorme, infinito, Zeppelin. A Pablo ogni tanto capita di entrarci dentro. Non sa come succede. Non è che ha le chiavi. D’improvviso, arriva l’attimo e si ritrova lì. Ma deve fare veloce, mica ci può stare tanto, a girellare dentro. L’attimo è breve breve.
È un flash. Devi prendere il seme della canzone e poi esci e ripiombi sulla Terra. Dopo, sono tutti affari tuoi. Ci sono tanti bischeri che se lo perdono, quel seme. È facile. Basta credere che il seme cresce da solo, che basta andare in studio e fare da da da…non funziona così. Io prendo il seme, lo metto in un piccolo vaso e lo nascondo nel mio giardino segreto. Poi lo annaffio ogni giorno, e non ci faccio entrare nessun pensiero. Il seme ha solo bisogno di acqua, di terra e di sole. E di uno che lo coccoli e non lo lasci lì a morire. Così cresce e alla fine vado in studio e gli fo, al Polipo…”senti, che ne dici di questo da da da…”. E lui chiama gli altri, e ognuno canta, suona, picchia, ride, si incazza, beve, fuma e poi quando è il momento, il Polipo ci mette tutti dentro alla stanza col vetro. Così prima o poi diventerà il da da da di milioni di bocche. Dicono che a volte s’arriva così al successo. Basta aspettare. E io aspetto, tanto la fila è quasi finita, è arrivato l’attimo e ho preso il seme.
….
LEONARDO
Eccolo qui. Il disegno è finito. All’Accademia fin dall’inizio mi hanno insegnato a stare attenti alle proiezioni e alle proporzioni. In una parola, alla prospettiva. Il dono della luce del Rinascimento dopo il buio del Medioevo. I piedi dei santi che si piegano, non stanno più tutti belli di profilo che paiono quelli degli egizi. I volti che diventano scavati, rubicondi, asimmetrici o armonici, veri, vivi. Il quadro esce dalla cornice bidimensionale. È nata la profondità, quella che ti fa vedere piccolo il lontano e grande il vicino. La prospettiva, l’immagine che si fa apertura di tutto quello che si vede, che rende lucida la mente e la fa galoppare dentro. E adesso all’Accademia io insegno che tutto nasce dal disegno. Il disegno non è solo la base del dipinto, ma è anche la proiezione della sua anima. Un attimo prima di essere un disegno, un momento prima che la mano lo abbia tradotto, quel segno è l’anima del concetto. La forma ancora occulta prende luce da quella matita che se ne sta alla fine dei polpastrelli e diventa visibile a tutti. Senza quell’anima, il dipinto non reggerebbe. I colori se ne andrebbero a giro per la tela, liquefatti perché incapaci di farsi strade o sentieri. Senza il disegno, il pennello sarebbe solo vento colorato.
Il cavalletto traballa un po’. Del resto, quando un pittore vuole dipingere dal vivo, deve coesistere anche con il suo terreno imperfetto, sconnesso, libero dalla geometria di un pavimento. Sennò dovrebbe dipingere su di un piedistallo. E non sarebbe la stessa cosa. Ci sono persone che vogliono vivere sui piedistalli. Non capita solo agli artisti. Per sua fortuna, Leonardo non fa parte di quella genìa. Lui dipinge il contatto. La tela è un ponte tra il suo mondo e quello degli altri. Se chi guarda il suo quadro ci intravede anche il proprio di mondo, lui ha raggiunto lo scopo. Non è più solo. Oggi tira vento, un vento caldo come fosse estate. Il cappellaccio di paglia sdrucita vorrebbe andare a farsi un bel giro nel bosco davanti, deve reggerlo con una mano carceriera.
Ti piacerebbe volare, eh! Forse hai anche tu un’anima, che sorride quando mi ripari dal sole che mi brucia il naso. Magari ti domandi chi me lo faccia fare di usare il tempo che mi avanza tra una lezione e l’altra per andarmi a mettere sopra un poggio che dà su un bel boschetto a fare il Pittore. Lo vuoi sapere?
È la mia anima che bussa. Vuole vedere con i suoi occhi se quello che le racconto è davvero la verità. Perché se la convinco, lei si dipinge. E io la ringrazio con due carezze di acquerello, sempre diverse, sempre vive. Perché noi pittori non possiamo vivere la nostra verità, se non la vediamo affiorare dalla luce accecante di una tela bianca.