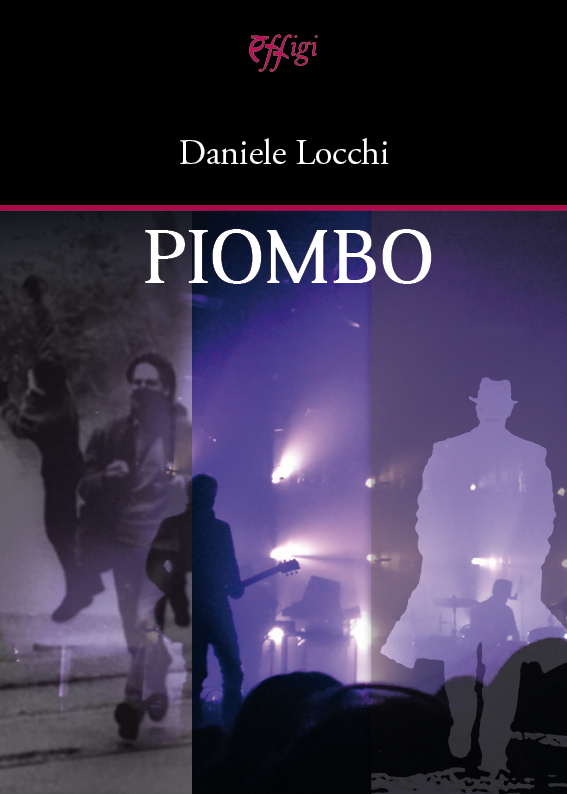C’è un uomo, un cane e una fila di case. Quartiere alto, vista sul parco inclusa. Dalle finestre dai vetri zigrinati si notano solo ombre. Segretarie, clienti, consulenti. Studi legali affollano il primo piano. Sopra, l’universo di appartamenti gelosi della loro appartenenza al mondo che non teme la becera mescolanza dei gesti e delle grida di strada. L’uomo guarda il consueto scenario del rito del rientro. Sono donne alte, bionde, impellicciate. Sono bambini con i pantaloni corti e le ginocchia sbucciate. Sono uomini in grigio, in nero, in blu. Molti con la borsa di pelle, chiusa da una cinta forata da punte di metallo cromato. Le donne hanno ciprie che intiepidiscono i lineamenti stanchi e capelli perfetti, laccati, con onde del mare biondo cenere a disegnare la movenza di sentimenti che sono andati via senza avvertire, come i maggiordomi non fanno e gli autisti nemmeno.
L’uomo sale con il suo sguardo da funambolo che si aggrappa alle grondaie, supera le ringhiere dei terrazzi, si sospende tra l’uno e l’altro, balza su agganciandosi alle mattonelle che avanzano oltre al linea del ferro battuto che divide la bellezza dello sguardo dall’orrore del salto indeciso tra il cadere volando o il volare cadendo, per la libertà di una fuga senza meta. Per un momento lascia la sua anima colorata in braccio allo sguardo equilibrista e osserva il cane. Un cane piccolo, di quelli che sembrano finti e schiumano rabbia per non essere nati liberi. Un cane vero, piccolo. Che mugola e abbaia, in sordina, come ogni cane di un palazzo dal portone importante ha imparato a fare, pena la cacciata dall’eldorado di Purina. Si china e sussurra alla palla di pelo.
“Buono Alaforte, sennò è la volta che ti faccio fare un bel volo dall’ultimo piano..una disgrazia ahimè, non ho idea di come sia potuto succedere, era come un figlio per me…che dolore…”
Alaforte che non ha mai cessato di odiare quella voce e quel nome così poco da Jack Russel, capisce anche il senso non solo il suono delle parole. E il marciapiede torna a zittirsi, una pausa lunga come la distanza tra il pollice e il medio prima dello schiocco.
L’uomo torna dal suo sguardo. Eccoci. Casa. Dolce. Casa. Un attico. Un appartamento. Grande come tutta la pianta del condominio di sotto. C’è una finestra aperta di fianco, sul lato nascosto perfino ai piccioni. Lo sguardo entra, attraversa il salone con quadri di chissà chi alle pareti, mobili antichi, c’è un comò, un settimino, un armadio vetrina, una scrivania in ribaltina, un about jour al tavolino ovale con il pianale in vetro, che se ne resta zitto di fronte al camino. Sedie, poltrone, riviste addormentate. Quattro finestre, una di fronte all’altra e due che fanno da gemelle sulla vista del parco che ha acceso le sue candele ai lampioni in attesa di farle diventare stelle alla notte delle signore dalle taglie forti che tramandano sesso. Amanda, Luisa, Morena, Luana…ogni nome un odore di profumo grezzo, invadente, offensivo. Ogni nome una doccia che lava via il disgusto di sapere di essere solo anche con qualcosa di tuo nelle cosce di un’altra. L’uomo le chiama “le streghe del Parco”, le guarda con vergogna mentre vede la sua forma seminuda alla luce della luna tra le braccia dell’erba che gli solletica le anche scoperte quel tanto che basta. Eppure il chiarore delle stelle quelle signore le disegna belle, proprio come il profilo di sua madre che fa capolino dal quadro che inaugura la parete del corridoio. Per fortuna, si dice, il Parco non ha specchi, ma solo alberi discreti e complici. Alaforte strepita, vuole tornare alla cuccia di legno che il padre dell’uomo gli ha costruito pezzo dopo pezzo, prima di addormentarsi per sempre appena finito l’ultimo colpo di martello. Un colpo più debole, quasi un addio del martello col chiodo e del cuore dal mondo. Il corridoio adesso è buio, le mani dello sguardo dell’uomo strusciano la parete fino scovare l’interruttore. Un flash a percorrere le mille possibilità di trovare la cucina, fino a fermarsi davanti all’odore di soffritto che lo ha da sempre rivestito per le corse alla fermata del bus del liceo. Ai fornelli una signora fatta cuoca con i capelli raccolti in una crocchia appena accennata, quasi un legame ai capelli bruni per non farli correre lontano, dal collo alle orecchie e poi sulla fronte, aggiusta una pentola grande sul fuoco. Lo sguardo dell’uomo si avvicina in punta di ciglia, le soffia da dietro una lenta carezza d’aria sul collo. La donna signora e cuoca si gira di scatto mettendo in mostra due topazi incastonati tra gli zigomi e le sopracciglia che fermano le poche gocce che le affrescano la fronte richiamate dal calore della magia del fuoco che insaporisce la vita. Vorrebbe abbracciare quell’uomo così troppo giovane da non poterle che essere figlio. Ma non c’è niente davanti a lei, se non il desiderio forte di un ricordo. E quell’uomo vorrebbe sorriderle, scostandole con un dito gentile la ciocca ribelle che le adorna la guancia, e dirle una frase, breve, un soffio di parole che si vanno ad accovacciare davanti ai topazi lucidi.
“Ciao, mamma. Come stai?”. Ma lei non lo vede e lui non la sente. C’è solo lo sguardo, di un uomo, laggiù, con un piccolo cane e una strada con una fila di case.